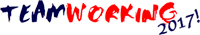18 Ott Collaborare anche quando il gioco si fa duro
Le forme di collaborative innovation rompono l’argine della fisicità e vengono applicate anche nel hardware. Bisogna imparare a collaborare anche quando il gioco si fa duro!
La collaborative innovation (Ci) è da qualche anno considerata la best practice per innovare. Per Ci si intende una filosofia di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi che abbandona sia la convinzione di riuscire a innovare nell’ambito di una singola impresa sia i timori di condividere i segreti legati all’innovazione. Al contrario, è un’innovazione che abbraccia le opportunità di condivisione di informazione e conoscenza.
La Ci si è fatta strada nei laboratori di r&d e nelle funzioni di design e marketing di alcune delle aziende più aperte al cambiamento sia a livello locale che globale. Dai casi più sobri in cui la co-progettazione avviene attraverso una rete di alleanze (il settore farmaceutico), a quelli in cui l’innovazione avviene grazie alla condivisione delle competenze di clienti e ricercatori (Procter & Gamble e L’Oreal), sino alle forme di innovazione integralmente co-creata da un’impresa (come in InnoCentive, Threadless e Lego) o da comunità orchestrate dagli stessi utenti (come in Linux), la Ci pare aver intrapreso un percorso di diffusione irreversibile.
Oggi due soli fattori ostacolano una diffusione anche più ampia e veloce: l’atteggiamento culturale di molti operatori e la fisicità dei prodotti. Superare timori e rischi legati alla condivisione di un bene prezioso come l’innovazione rappresenta una sfida che richiederà ancora alcuni anni per essere metabolizzata. La Ci impone l’abbandono di una logica di scambio strettamente economica (come insegna il premio Nobel per l’economia 2009 Elinor Ostrom) a favore di un approccio legato ad aspetti meno razionali, non semplici da accettare per una generazione abituata a una nozione proprietaria di innovazione. Il secondo aspetto riguarda invece i vincoli d’interazione per i prodotti tangibili. Le parole che permettono di co-innovare su Wikipedia e i codici che consentono a Linux di far propria la conoscenza di molteplici user si prestano alla Ci molto più di quanto possano fare i prodotti e servizi che caratterizzano gran parte degli operatori economici. I primi casi di open source hardware (Osh) aiutano però a capire come superare questo secondo ostacolo.
L’Osh è una pratica emersa nello sviluppo di diversi prodotti, dai sintetizzatori ai telefoni cellulari. Centinaia di inventori di hardware hanno cominciato a pubblicare le loro specifiche di prodotto, dando vita a innovazioni inimmaginabili alla fonte. Dall’Osh sono anche emersi nuovi progetti imprenditoriali, come Arduino, il primo microcontroller open-source. L’impresa che ha creato Arduino (http://tinker.it) rende disponibili online tutti i segreti commerciali relativi a questo nuovo tipo di circuito elettronico: oltre al software, l’azienda mette apertamente a disposizione della comunità degli utenti le specifiche e i disegni originali delle parti elettroniche. Scaricandoli, ognuno può costruire Arduino da solo e personalizzarlo per poterlo implementare all’interno del proprio prodotto, da un personal robot a un motore d’auto.
In questo modo, l’Osh viene a caratterizzarsi quale processo che consente di separare la fisicità dell’oggetto dalla sua componente progettuale. Si lavora a partire da un codice sorgente, che viene poi adattato alla varietà di prodotti per i quali si vuole immaginare la soluzione. E stimolando la creatività dei singoli e la loro imprenditorialità. Grazie all’Osh, la collaborative innovation acquisisce credibilità anche in contesti industriali originariamente inaccessibili a causa dei vincoli fisici del prodotto. E così facendo, dischiude ulteriori porte al futuro dell’innovazione.
Di Emanuela Prandelli e Gianmario Verona, rispettivamente, vicedirettore del Centro di ricerca Kites Bocconi e direttore del PhD in business administration della Bocconi
Tratto da: http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=2845